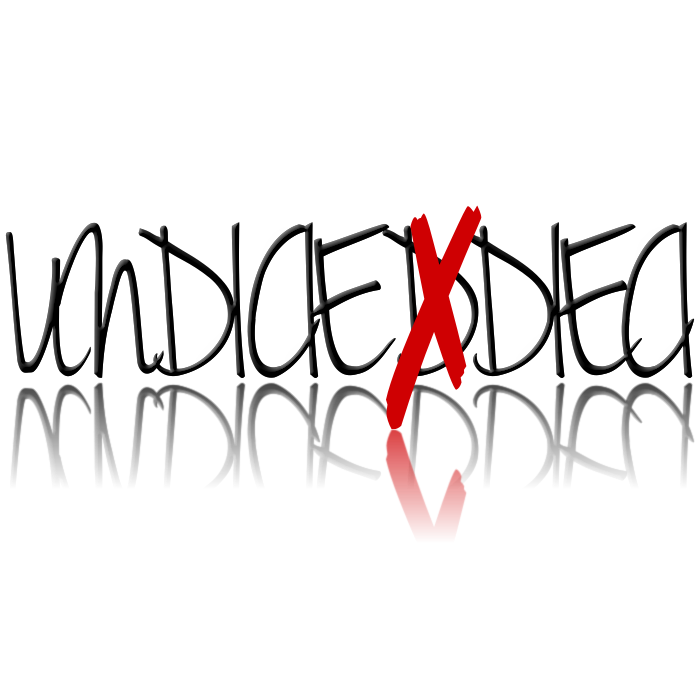Quando aprii il cassetto della biancheria intima e notai che le uniche mutande contenutevi erano quelle dei Power Rangers, di quando ero bambino, capii subito che quella sarebbe stata una giornata piena di sorprese. Era una di quelle mattinate umide, grigie, insignificanti. Quella sorta di nonsense me la portavo addosso da quando mi ero svegliato, la avevo trascinata con me sull’autobus e poi fino al banco di scuola. Primo banco centrale, un incubo. Durante le ore di filosofia essere seduto al primo banco centrale significa essere costretto ad un ruolo mostruoso di passività, ad una condizione servile e di puro sacrificio. La colpa di non essermi svegliato presto il primo giorno di scuola, la colpa di non aver lottato, gomito a gomito nella fiumana sudata dei corpi che occupano il corridoio, mi aveva relegato lì. Come Prometeo incatenato alla roccia, io ero vittima delle elucubrazioni kantiane, declinate con fare sadico e compiaciuto dalla prof: così come ogni notte l’aquila portava via al titano un pezzo di carne, ogni minuto che passava uno dei miei giovani neuroni si spegneva, un grigio sentore di indolenza e di immobilismo esistenziale mi avvolgeva in un torpore trascendentale. Vittima della riscoperta post-kantiana dello spinozismo e della concezione romantica di Sensucht, fissavo la luce gialla al neon sopra di me, che si accendeva e si spegneva, poi si accendeva, per poi spegnersi e riaccendersi di nuovo, e di nuovo inaspettatamente si spegneva, e così avanti per circa una decina di minuti.
Ma quella non era una giornata come tutte le altre, lo avevo capito sin da subito, da quando avevo dovuto indossare quegli slip assurdamente stretti. Proprio mentre nell’aula echeggiavano discorsi lunari sulla tendenza idealistica all’infinito, in me vedeva le sue origini un nuovo tipo di tendenza, più profonda ed intima: quella verso il gabinetto.
“Venti oscur
sovra l’appendice
forman un ciclon
di madida radice.”
Con voce impossessata da quel demone molto poco socratico mormorai, come se stessi intonando i versi di un qualche carme oscuro:- Ehm, ehm, uhm, ahm… possooo… andareinbagnooo?- La prof, abituata ormai da anni a quelle mie intonazioni gutturali, rispose senza proferir parola, semplicemente annuendo solennemente col capo, con un sorriso accennato sul volto.
Il gabinetto del Vivona, quello del mio corridoio, mi è sempre stato molto caro.
Sin dal primo anno trovai tra quelle mattonelle un nido caldo, una tana pronta ad accogliermi e a portarmi via per qualche istante dalle fatiche terrestri. Beato, ammiravo le scritte a pennarello sulle porte, quelle epigrafi segno del passaggio di generazioni e generazioni di vivoniani. Esempi raffinatissimi di poesia, del tipo
“Corri còr cantante
fra faville di strada.
In queste stagioni sante
ti sia data
una speranza.”
Eccomi, lì nella mia angusta galleria d’arte, a interrogarmi sul senso della Storia. Stavo canticchiando i versi di qualche coro da stadio, quando il mio sguardo cadde su di una mattonella della parete alla mia sinistra, che sembrava sfalsata rispetto alle altre. Mi alzai, con le brache ancora calate, per osservarla da vicino, ma, non appena la toccai, quella cadde, rivelando una piccola cavità nel muro. Riconobbi la forma di un giornale all’interno del nascondiglio. Infilai il braccio, e quando lo tirai fuori, insieme a qualche fogliaccio vecchio ed ingiallito, capii di avere tra le mani qualcosa di estremamente prezioso, qualcosa che avrebbe sicuramente reso quella giornata indimenticabile.
NOVEMBRE ’68 – IL GRILLO PARLANTE DEL VIVONA
Ero entusiasta della mia scoperta, se non altro perché avevo un motivo in più per non tornare in classe. Non appena girai la prima pagina, mi sentii diverso, la testa cominciò a girare, e, per pochi secondi, mi sembrò di percepire nell’aria strani canti, come tribali, e un forte odore floreale. Dopo qualche minuto mi stancai di quella lettura e mi rassegnai a tornare in classe. Accartocciai il giornale in una tasca ma, prendendo le mutande per indossarle, mi resi conto che i disegni dei miei eroi infantili erano scomparsi. Non mi ricordavo di aver indossato dei mutandoni di cotone, tipo quelli di mio nonno, ma mi sembrò più probabile che i Power Rangers fossero un frutto del torpore del sonno, un’allucinazione provocata da una cena troppo abbondante, e che, nella confusione di quella mattina, avessi veramente indossato i mutandoni del nonno. Alzatomi in piedi, udii un gorgoglio cupo, profondo, infernale. Una folata di vento si alzò da terra e mi avvolse, scompigliandomi i capelli. Poi, nel giro di pochi secondi, tutto tornò come prima. Attribuendo questa serie di visioni alla mia già difficile situazione psichica, aggravata da due ore di Kant, uscii di corsa dal bagno ma, con rinnovato stupore, mi accorsi che il corridoio era vuoto. Entrai in classe e trovai vuota anche quella: tutto era rimasto uguale, tranne che per il computer sulla cattedra, che era scomparso, e per i cappotti appesi al muro. La mia giacca a vento North Face era stranamente sostituita da uno spolverino di lana cotta. Mi precipitai sul pianerottolo, per chiedere spiegazioni al bidello. Non trovai nessuno. Sulla porta, però, era affisso un cartellone bianco con la tabella degli orari dei professori. La prima riga recitava: ORARI PROFESSORI LICEO VIVONA- ANNO SCOLASTICO 1968-69.